Non so se sia un fatto normale e valido per tutti, ma ho l’impressione che ogni tanto la vita assuma fattezze terribilmente simili a quelle narrazioni che, nel bene e nel male, più di ogni altra ci (s)colpiscono. Che si tratti di una storia che conosciamo da sempre, di una frase particolare che ci è stata detta, di un sogno fatto anni prima e sempre ricordato, o magari di un déjà-vu ricorrente, a volte le correspondances affiorano in superficie, tenaci, ineluttabili, plasmanti.
Sin da piccola ho sempre custodito uno spazio mentale in cui sognavo di far parte degli X-Men. Nell’universo giovanile spesso stucchevole e lineare popolato da bambole e personaggi Disney, gli X-Men erano esseri di carta già complessi, poliedrici, adulti. Parlavano per nuvolette, a volte volavano o sparavano raggi laser dagli occhi, ma erano più reali di tutto il resto. Passavo ore a immaginarmi nei panni di eroine come Rogue, Storm o Shadowcat. Ma soprattutto in quelli di Jean Grey, la timida studentessa dai capelli rossi in grado di vedere cose a cui altri non hanno accesso, e di smuovere montagne con la sola forza della mente.
Giusto per quei pochi che ancora ne fossero all’oscuro, e lasciando perdere gli edulcorati adattamenti holliwoodiani: gli X-Men sono quella non troppo allegra banda di personaggi dei fumetti affetti da una mutazione genetica (il gene mutante o gene X, appunto). Un’alterazione del DNA che li dota ciascuno di una specifica abilità sovrannaturale, che è insieme un potere e un danneggiamento, potenziamento e maledizione; e di un ameno corollario di disagi, relativi alla difficile gestione della faccenda e alla convivenza con gli umani “normali”.
Dal giorno in cui si manifesta, la mutazione non li abbandona più, fa parte di loro tanto quanto il naso o l’ombelico, e i nostri si adoperano per nasconderla nel tentativo di apparire come tutti gli altri e di non farsi guardare con sospetto (o peggio). In certi contesti, però, questa stramba e perturbante disabilità li aiuta e permette loro di sopravvivere. In altri casi, li costringe a compromessi a cui non avrebbero mai pensato di scendere. La mutazione li rende altri, alieni, devia la loro direzione di crescita, trasforma la loro visione del mondo. Li avvicina gli uni agli altri e al contempo li isola irrimediabilmente.

Un’altra delle caratteristiche che amavo di questo universo era la coralità. Spiderman, Batman, Superman… questi protagonisti assoluti ed eroi solitari si stavano perdendo qualcosa. Il guadagno, ai miei occhi, stava nella condizione comune, nel gruppo e nelle sue dinamiche interpersonali, nel senso di appartenenza, nella consolazione di sentirsi danneggiati, sì, ma non gli unici.
I mutanti per me sono sempre stati questo: carisma e dannazione, smarrimento e resistenza, capacità di fare grandi cose senza averlo scelto o esserselo augurato, in un mondo spesso immeritevole e volto al male, all’entropia. Tante volte ho sperato che mi venissero a prendere e che mi portassero via con loro.
E a furia di immaginarlo, un giorno, anzi una sera, un venerdì 13, mi è capitata quella famosa brutta cosa che ha modificato indelebilmente la mia traiettoria.

Già i miei sensi si mettevano all’erta, poco prima, come Jean Grey quando intravede il suo destino sotto forma di una Fenice che muore e rinasce. Guardavo dalla finestra una Parigi ingrigita del mio umore, ripensando a come la sera prima nel rincasare fossi sfuggita correndo a un’aggressione in strada, e improvvisamente mi si rivelava una premonizione: “Non sei al sicuro. Succederà qualcosa di più grosso, e non te la caverai così facilmente”. Non credo ai presagi né a nulla di simile, ma la sensazione era lì e non se ne andava. È stata l’unica volta nella vita in cui ho provato qualcosa del genere. “Sta per succedere. Sarà enorme e apocalittico. Riguarderà molte persone, ci sarai dentro e non sarai protetta”.
Nel mondo degli X-Men, la mutazione si manifesta in un individuo improvvisamente, con sorpresa e violenza, nel momento in cui uno è maggiormente inconsapevole, le difese abbassate; e sconvolge tutto quello che il soggetto crede di sapere sul mondo e su se stesso. E i contorni della mutazione sono talmente cangianti che possono volerci anni prima di conoscerla del tutto, figuriamoci per domarla.

Io in quel momento stavo ascoltando della musica.
Il mio gene mutante si chiama PTSD.

Oggi lo conosco, vivo una vita normale e non ci penso. Ma il gene è inscritto in me e non se ne va via così. Silente, beffardo, di tanto in tanto decide di innescarsi e si riattiva. Mi toglie qualcosa e mi dà qualcos’altro.
Il PTSD è uno specchio rotto in cui non ti rifletti più. È l’esplosivo nel cemento armato delle fondamenta di quella personalità che per anni hai faticosamente, e vittoriosamente, costruito, fino a rivestire il caos di equilibrio dorato e scintillante. I materiali dell’edificio sono ancora tutti lì, ma c’è soprattutto polvere, rovina e disgregazione, c’è bisogno di ricostruire ma tu non te ne intendi, e poi c’è sporco, marcio, e prima dovresti ripulire, ma con cosa?
Il PTSD è una carica esplosa male, che nessuno sa come maneggiare restando indenne. Sono certi limiti che negli altri hai sempre odiato, sprezzante, finché non diventano i tuoi. Sono le scatolette con foglietto illustrativo sul comodino. Sono i fuochi d’artificio che a Capodanno non hai la forza di andare a vedere, perché non sai più la differenza tra un petardo e un colpo di kalashnikov, e perché tu sei una sopravvissuta, ma chi è con te ancora no e perciò va protetto, preservato. Il PTSD sono le spiegazioni ulteriori a chi ti sta vicino; sono i sensi di colpa, perché detesti ripeterti ma a volte sei proprio intrappolata in uno di quei disegni di Escher in cui si entra e non si esce; è allontanarti in silenzio, quando giustificarti diventa troppo arduo. Il PTSD è ridere delle tue disgrazie e non di quelle altrui. Sono le visioni di sangue di giorno, a ciel sereno, su un prato o sulla spiaggia. È l’istinto di localizzare sempre l’uscita di sicurezza, esaminando anche ogni grata nel cemento. Sono i sogni periodici nella notte nei quali sei indifeso. Sono spazi e delimitazioni precedenti che non ti corrispondono più. È la paura che la gente ti veda con un’etichetta in fronte, che ti riassuma, che ti compatisca. È il tormento della scelta se parlarne o no a chi ti ama, e in che misura. È una diversa concezione del futuro, del tempo che ti resta, è quel velo sgargiante attraverso cui vedevi il mondo e che ti hanno strappato e gettato via lontano, nel fango. Il PTSD muta sempre, come il fiume di Eraclito, e non lo puoi fissare per dirlo. È una perla di cristallo iridescente che non rotola in linea retta. È attrazione per il macabro: un macabro che ora per te è il familiare, che ti ricongiunge con il superamento di un confine che di solito non si oltrepassa. Un confine che una volta che l’hai varcato rimane parte di te, e che quando lo incontri vi salutate cordialmente con un rapido cenno del capo, quasi sollevati, perché ormai vi conoscete, il mistero è venuto meno.
A volte per farmi coraggio penso a Jean Grey, con le sue premonizioni catastrofiche, i suoi poteri a volte incontrollabili, il suo aver visto cose terribili non di questo mondo, la sua sofferenza, ma anche alla grazia, la dignità e la sopportazione con cui ha sempre affrontato i suoi demoni, a testa alta. Cerco di prendere esempio. In quell’universo avrei scelto di essere lei.
Un universo che è collettivo, dicevo. Same here. Perché quello che è accaduto a me quella sera è toccato anche ad altre millecinquecento persone. Novanta non sono più tra noi. Tutte le restanti sono mutate, similmente eppure ciascuno a suo modo. A qualcuno quel gene è stato inflitto con una carica a scoppio ritardato, che per ora sonnecchia ancora, ma che un domani si risveglierà. Fatto sta che, senza averlo chiesto, ce ne andiamo nel mondo con il nostro gene alterato, ci mescoliamo agli altri e ad altre mutazioni. La nostra non si vede, non emettiamo raggi laser dagli occhi, non ci spuntano artigli dalle nocche. Siamo come gli altri. Siamo i nostri simili.

La mia mutazione è una condanna da scontare per colpe non commesse se non quella di stare al mondo, perché nessuno ne esce indenne, anche prima di uscirne definitivamente. Eppure, nei momenti di maggior tranquillità, arrivo a vederla come un dono, un potenziamento. Un ponte telecinetico verso cose che un tempo non mi appartenevano, che non avrei saputo vedere né capire. A volte è energia pura che si sprigiona da me, come quando Jean è disegnata in volo, con quel suo contorno rosso-rosa splendente tra le fiamme.
La mia mutazione è l’assenza di paura di cose che un tempo mi avrebbero terrorizzata. È empatia, resilienza e sete inestinguibile di nuovi paradigmi e abilità. È resistenza decuplicata alla pressione, perché non appena inizio ad agitarmi per qualcosa o qualcuno, penso alle mie visioni, e tutto il resto perde di gravità, contano solo l’ossigeno che respiro e il sangue che mi scorre nelle vene, e tutto va bene. È coscienza di avere il diritto di esserci, di difendere i miei confini quando occorre, di osare superarli quando conviene. È libertà di sperimentare e di non giudicare, è imparare ogni giorno a lasciare andare. È il rammarico di non avere mille vite, ma solo due, e di essere già alla seconda. È indulgenza, accettazione e una conoscenza nuova di tutto quello che sta intorno.
La mia mutazione di sicuro è impegnativa, quello sì. Non la augurerei ad altri, ma tant’è, è toccata a me e va bene così. Magari nella prossima vita mi limiterò a giocare ai LEGO, invece di comprare fumetti, e le correspondances mi porteranno altrove. Ou pas, chissà.

[All images on this page are from the Web. I don’t own any credits to them]


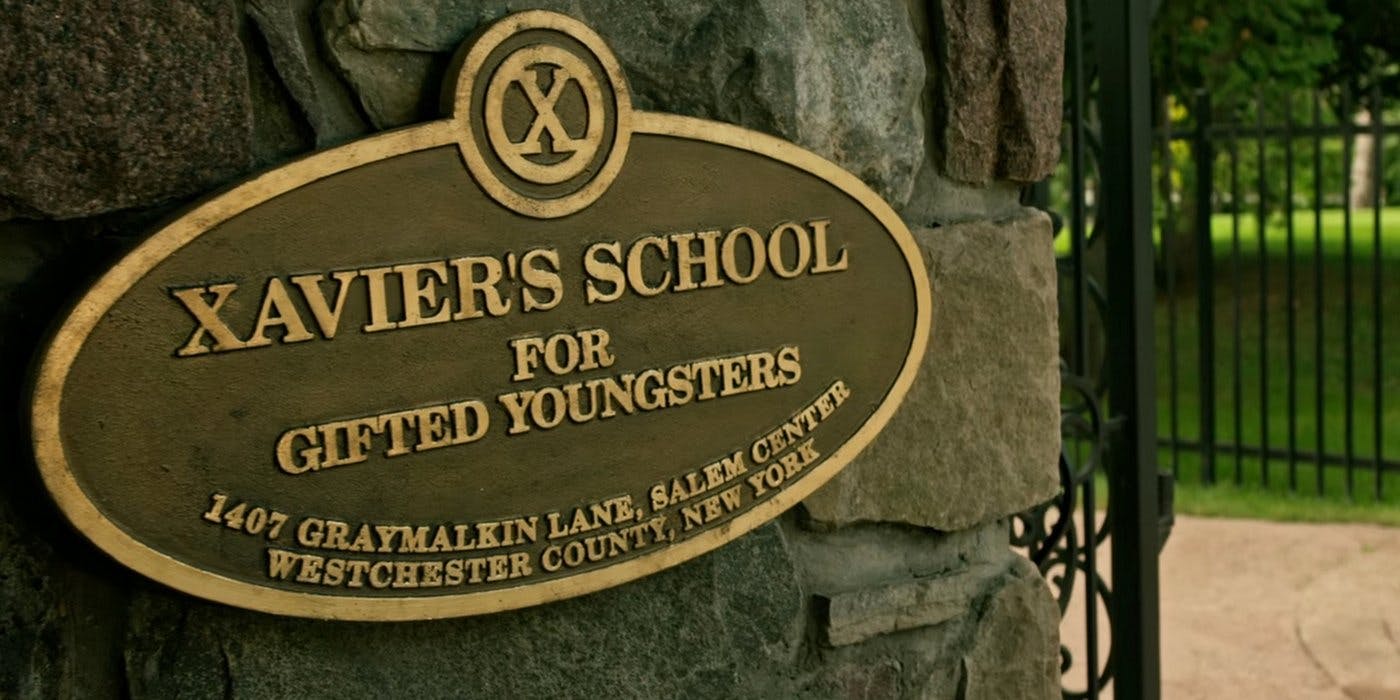



Lascia un commento