
Una
Polly è arrivata con un bagaglio, uno di quelli che per il troppo peso costringono a soste ripetute. Dolorava, pur essendo in perfetta salute. Non ne voleva sapere di niente e di nessuno. Si faceva vedere solo per i pasti, agguantava i pezzi migliori e se li portava via, per sbocconcellarseli in solitudine. In pratica era come me, solo più fragile e più bulla; per questo l’ho subito amata alla follia. Mentre si nascondeva, le ho bisbigliato: “A te adesso ci penso io”.
Mi guardava con aria supplichevole: “Ti prego, lasciami in pace”. In risposta, la lodavo. Allora cercava di intimidirmi con sguardo truce: la lodavo. Non importava cosa facesse per scoraggiarmi. La lodavo e le sussurravo: sei libera. E sei al sicuro. Sedeva, vigile, sempre all’erta. Le parlavo e mi muovevo piano, per non spaventarla, non farle insorgere brutti ricordi. Evitavo i rumori. Le davo attenzione. La premiavo e lei non capiva perché. Diffidava dei miei tentativi di convincerla che fosse meritevole intrinsecamente. Non si capacitava. Avrei vinto io, questo l’avevo saputo a prima vista.
Due
Polly era una ragazza madre: è arrivata con Molly, piccina, che era il suo opposto. Molly brillava di una luce interiore tutta sua, che non aveva assorbito da nessuno. Faceva saltini di gioia immotivati. Era una creaturina assertiva e curiosa, che aveva bisogno di correre e di scatenarsi. Possedeva uno scudo energetico che la rendeva impenetrabile al disagio tutto intorno: lei era sempre felice, per qualche imperscrutabile ragione. Faceva piroette. Imparava. Al contrario di Polly, talmente sfiduciata che non osava mai chiedere nulla, Molly teneva in gran conto i propri desideri. “Voglio questo!!”, e naturalmente lo otteneva. La sua allegria non solo si autoalimentava, ma era contagiosa. Faceva un sacco di nuove scoperte, di discorsi tra sé e sé, si raccontava storie.
Nonostante la sua mamma si mostrasse piuttosto insofferente a lei, lei la adorava di un amore inestinguibile e devoto. La mamma era il suo idolo, il suo modello. Dalla mamma apprendeva a diventare adulta. L’ho vista emularne via via i comportamenti, e incedere soddisfatta dopo ogni prima volta, con l’aria importante. La mamma che, come veniva fuori quando Molly si infortunava, se ne disinteressava solo per finta: allora accorreva tutta preoccupata, e a pericolo scampato si lasciava andare a una felicità speciale, non autocensurata.
Erano Polly e Molly ed erano i miei grandi, piccoli amori.
Polly e Molly sono due porcellini d’India; ma come amavo ripetere loro, la loro specie non era essenza, bensì puro accidente. Per me erano due anime amorose, incontrate al momento giusto.


Amore e felice oblio
Aspettavano sempre la sera, il gran momento del divano. Molly adorava giocare a fingere di lanciarsi giù per farsi acciuffare. Guai a lasciarla sola per un secondo: chiamava, voleva saltare in braccio. Con il tempo, la sua felicità interiore si era fatta meno a sé stante e più dipendente da noi altri: bramava la vicinanza, il contatto. Prima aveva troppa energia per stare ferma a farsi fare le coccole; cresciuta, non chiedeva altro, e ci ricompensava con versetti senza fine. Ci aveva tutti in pugno, nel cuore. Un cuoricino pulsante che quando si agitava faceva “Tum-tum-tum!” a mille all’ora. Andava pazza per il peperone rosso; dormendo muoveva le orecchie.

Polly, la burbera, era la mia vittoria segreta. Il fatto di essere amata senza aver fatto niente le rimaneva incomprensibile, ma se ne era fatta una ragione, e la cosa non le dispiaceva affatto. Aveva cominciato a fidarsi. Non scappava più: si avvicinava. Veniva a sedersi al mio fianco e stava zitta. Con il tempo permetteva persino a Molly di sdraiarlesi accanto, e di mordicchiarle affettuosamente le orecchie. Squittiva di piacere. Al mattino, la sorprendevo a saltellare di gioia al mio apparire.

Mentre la accarezzavo aveva preso ad autotrasportarsi in un posto tutto suo: il pianeta dell’oblio, quello dove si dimenticano i traumi passati e le ingiustizie subite. Si abbandonava completamente, e si risanava un po’ di più. Mentre viaggiava con lo spirito, le veniva l’occhio matto, quello del piacere esagerato e godereccio. Avrebbe vissuto così per sempre.

E invece.
Un precedente
Quando ero una ragazzina senza voce in capitolo sulla vita, a casa avevamo un cane, un animale dolcissimo. La mia famiglia, nella quale convivevano svariati problemi mentali e relazionali, di punto in bianco decise che per motivi arcani non lo voleva più, e il cane fu ricollocato. Sieg Heil.
Perciò, quando ho dovuto riaffidare Polly e Molly per l’unica ragione più grande di me (trasferimento imprevisto da un continente all’altro e un lungo viaggio aereo al quale, data la loro natura, non sarebbero mai sopravvissute), lo conoscevo già quel triste senso di vergogna, di sporcizia morale, di lordura interiore che si instaura nell’animo sin dal primo momento in cui capisci di essere costretto a lasciare andare il tuo animale. L’impotenza, la frustrazione, il cuore spezzato. Da adulta, artefice delle tue azioni, è anche peggio.
Come glielo spieghi? Cosa racconti, a quegli occhi buoni e interrogativi? Come impartisci al tuo corpo il vile comando di depositare il trasportino in mani altrui, pur fidate?
Come riparare lo spirito da una tristezza che, pur non essendo quella di un lutto, di certo è ancora meno nell’ordine naturale delle cose?
Piango perché mi mancano da morire; sorrido perché ho vissuto una cosa speciale, che non a tutti è data. Non so se ne guarirò mai, ma va bene così.
Il post scritto al loro arrivo:
Ti è piaciuto questo post?
Segui Lucy the Wombat su Facebook!
Iscriviti qui sotto per ricevere i nuovi post via e-mail (il tuo indirizzo verrà utilizzato automaticamente solo per questo scopo).
Grazie e buona lettura! 🙂
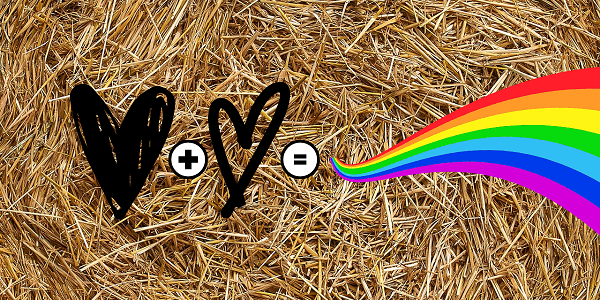
Commenti
56 risposte a “Cronaca di un doppio amore interrotto”
Mi ero domandata se ti fosse stato possibile portarle con te, ma a quanto pare hai dovuto lasciarle. Puoi sempre telefonare per sapere come stanno.
🙂
Non so perchè ma mentre leggevo piangevo, sentivo il distacco nell’aria. Penso avrai studiato bene la prsona a cui le hai affidate. Questo ti dovrà far sentire tranquilla, se staranno bene loro, starai bene pure te. Un abbraccio infinito!
Stingere un legame con un animale (che può comunicare solo con gli occhi e con il suo comportamento) è un’esperienza fra le più forti e profonde che un essere umano possa sperimentare. Capisco il tuo stato d’animo. Coraggio. 🙂
Un saluto. 🙂
Dovrei scrivere cuoricini rossi rossi anch’io sulla mia attuale gatta Tatablu (preceduta dalla tenerissima aristocratica Liz a sua volta preceduta dal duo Gidou e Fanny a loro volta….).
Differenza non da poco io ho il privilegio di non dovermene separare questo non toglie che tu abbia la mia comprensione.
Nota: Tatatablu, con la quale nei rari momenti in cui non è sprofondata nei più invidiabili sonni, scambiamo intensi discorsi e confidenze al punto che lei considera complimenti le mi tirate di coda – se incontrasse di persona i suoi “tesori”… ritengo che non occorra completare la frase.
Ciao, concittadina, la Madonnina mi chiede sempre di te…
* stringere.
💗💗💗💗💗💗💗
Che bella storia, adesso che ce ne hai messo a parte dispiace anche a noi, per Polly e Molly. Cosa si saranno chieste, ti aspetteranno ancora? Tenerissime.
😊 😊
Meglio così. Polly e Molly, due innocenti porcellini australiani senza difesa in Italia, un paese dove non puoi fare due passi senza inciampare su 48 gatti. 😱😱😱
Bonsoir Lucy,
Alex
Ah, ah, almeno si consolano!
Quello sì, certo. Grazie del pensiero :*
Errore: “se incontrasse di persona i “tesori”
Però hai tutelato la loro salute Lucy🖤
Grazie carissima 💖 Sì, su quello sono tranquilla. Cucciole 💖
Grazie mille, è la cosa migliore che ci si possa sentire dire. 🙂 💖
In realtà leggevo che i gatti considerano prede solo i porcellini cuccioli, con quelli adulti possono benissimo convivere. 🙂 Salutami Tatablu, beati voi. Aspetto il post cuoricini su di lei! 🙂
Era la cosa che più contava, non potevo rischiare. 💗
Ciao Ale, grazie 🖤🖤🖤
[…] Cronaca di un doppio amore interrotto […]
Amori, non ci voglio pensare! Però so che ora hanno un nuovo amico, un maschietto che era rimasto solo e ora si fanno compagnia. 🙂
Esatto
In Australia è molto peggio, credimi 🙂
Bonsoir à toi 🙂
Mi hai commosso.
Ti capisco benissimo…non so come reagirà quando la mia dolcissima cagnetta se ne volerà nei prati celesti. Già quanto è successo l’estate scorsa ha lsciato un vuoto che non avrebbe mai credutohttps://viaggiermeneutici.com/2020/08/01/anche-i-conigli-si-anche-loro/
Eh 💔
Oddio, non so se sono pronta per leggere 💔 Però gli animali quando muoiono vanno nel paradiso degli animali!
Only the brave! Ma d’altra parte che potremmo farne senza?
Avevo dovuto lasciare i miei gatti quando ero andata a vivere in Inghilterra, ma li avevo ripresa al rientro (in realtà avrei dovuto portarli con me, ma il creepy flat non era agibile, diciamo…). Mi dispiace molto che tu non abbia potuto portare le tue piccole con te e capisco la sofferenza. Ti mando un abbraccio ❤
So quanto ci tenevi alle tue pelosette e so che la decisione di lasciarle non è stata presa a cuor leggero, ma purtroppo non avevi alternative! Un abbraccio forte!
Sto vivendo esattamente la stessa cosa con la mia bassotta di dodici anni e lasciarla senza poter sapere più come sta e avere la consapevolezza di non esserle affianco quando tra pochi anni non ci sarà più mi distrugge. Hai ragione non penso passerà più.
Straziante.. comprendo il tuo dolore, gli animali sono compagni di una parte del viaggio, anime pure che sanno dare amore pulito, senza bisogno di assecondarti per farti piacere, o mostrarsi diversi da quel che sono. I miei hanno il potere di farmi iniziare la giornata con una gioia nel cuore, di farmela tornare nonostante tutto quello che può essere accaduto quando li vedo arrivate a casa.Con i due nuovi più giovani (gatti) a volte mi ritrovo preoccupata la notte o al mattino perché non sono rientrati, quasi mi facessero il training per i futuri anni della mia adolescente.
Comprendo il dolore del lasciare andare, quando diventa inevitabile, e la ricchezza che resta perché ti hanno accompagnato in quella parte di viaggio.
Comprendo quella delicatezza che si vede indispensabile, davanti a un’anima impaurita, e la riconoscenza che torna quando si vede che impara a fidarsi.. se continui ad usare lo stesso tatto, e quanto tutta questa cura sia indirettamente cura per la nostra anima ferita.
Un senso enorme di gratitudine per averle avute accanto, queste anime, e avere permesso di riprendere parti di noi.
Sei un tesoro, grazie 💜
💜
Mentre andavo avanti leggendo percepivo che c’era un finale triste…immagino quanto debba essere stato difficile per te. Chissà se Polly ne avrà risentito tanto…
Posso immaginare la pena e il coraggio usati per consegnare i tuoi amici in buone mani, con sensi di colpa e di impotenza. Posso capire il tuo dolore. Gli animali fanno parte della famiglia, diventano dei componenti insostituibili. Ma rimangono tali, anche da lontano. Sono sempre Polly e Molly e sicuramente, ogni tanto, penseranno a te e alle tue lodi. Non è detto che la sorte non vi ricongiunga…
Leggendo le tue parole sentivo il tuo dolore e soffrivo con te. Ho sempre avuto cani o gatti, e ogni volta che uno di loro è morto, una parte del mio cuore è morta con me. Le tue piccolette non sono morte, per carità, ma capisco che doversene separare causa un dolore del tutto simile. Non sono una persona da abbracci fisici ma te ne mando uno virtuale.
Mi hai dato una stretta al cuore. Non so se io sarei riuscita a lasciarle. Soprattutto non so a chi sarei riuscita a lasciarle. Non era possibile in nessun modo portarle con te? So che il viaggio è davvero troppo lungo, anche per addormentarle, ma non me ne intendo, non ho mai fatto viaggiare il mio cane in aereo. Forse per nave? Vabbe sto vaneggiando.
Ma che belli questi porcellini d’ India. Io adoro gli animali, soprattutto i cani, purtroppo ho dovuto addormentare la mia piccola Boston terrier a maggio, quindi non ho più un pet; in questo momento mi accontenterei di un gatto, di un pesciolino o di un criceto.
mi ricordo del loro arrivo! le ho amate da subito e il fatto che hai dovuto lasciarle mi ha profondamente rattristato. Speravo che saresti riuscita a portarle con te e ho sofferto per te e con te per il distacco da due creaturine così adorabili. Spero che abbiano capito, soprattutto Polly che aveva iniziato a fidarsi e non saprà spiegare l’abbandono, ma sono sicura che la loro nuova famiglia le farà sentire protette e felici, non può che essere così dato che l’avrai scelta tu
capisco la sensazione. Credo che i legami che creiamo con gli animali è qualcosa di indistruttibile e inspiegabile!
Spero che tu trovi conforto ❤️
No. Non posso leggere queste tue parole.
Mi si spezza il cuore e penso a quanto sia spezzato ora il tuo… Gli animali sono esseri davvero speciali, ci comprendono e ci danno amore incondizionato: uno sguardo, una carezza, questo chiedono. Capisco benissimo cosa stai provando perchè l’ho provato anche io. Se hai bisogno cara, non farti scrupoli, scrivimi!
Ricordo il post che avevi scritto quando le avevo prese, che gioia traspariva dalle tue parole. Questo è tutto il contrario, si sente tutto il dolore del distacco, di quella pace interiore spezzata nel doverle lasciare. Ti mando un grandissimo abbraccio, ti sono vicina.
😍
Grazie Patty per questo commento pieno di dolcezza. E scusa il ritardo. ❤
Oddio Silvia, mi dispiace :((
Per fortuna sono in contatto con chi le ha ora, dalle foto vedo che è sempre un po’ bulla e lo prendo come un segnale di salute 💕
A me basta ricevere ogni tanto loro foto (non ci speravo e invece sta succedendo) e vedere che stanno bene 💕
💖💖
Purtroppo no. I porcellini hanno bisogno di avere sempre cibo a disposizione, pensa che se dopo solo 6 ore dall’ultimo pasto non hanno più fieno la loro salute inizia a degradarsi e diventa grave velocemente. Per non parlare della loro fragilità di animali preda: a casa loro stanno bene, ma a ogni rumore o situazione imprevista (anche solo un estraneo che entra in casa) si spaventano tantissimo, sono così per natura. Impensabile metterle in un trasportino da sole per tutte quelle ore (nessuna compagnia aerea accetta porcellini in cabina con i padroni, su quella tratta). 🙁
Non puoi più averne? Io non vedo l’ora di cambiare la casa dove sto ora, così potrò riprendere un animale e non separarmene più.
Scusa il ritardo Anto, e grazie ❤ Effettivamente dalle foto sembrano stare bene, le aiuta moltissimo il piccolo amico che hanno trovato. Anche lui era rimasto solo e ora in 3 si fanno compagnia!
Scusa il ritardo anche qui, ho passato un periodo densissimo e mi sono persa persino i commenti al mio stesso blog. Grazie! 💕 Mi dispiace che anche tu abbia dovuto conoscere questa esperienza. Non la si augura a nessuno. Un abbraccio 💕
Perdonami del ritardo con cui ti rispondo. Le tue parole mi fanno un gran bene. Grazie ❤
Non leggo mai post di animali perché non mi regge il cuore, però mi hai incuriosita. Per fortuna nonostante la tua tristezza è una storia finita bene, non è morto nessuno e sono certa che li hai affidati a mani speciali. Un abbraccio solidale, anch’io ho dovuto lasciare un gatto molti anni fa e ancora non ho fatto pace con questa cosa.
Ouch, un abbraccio anche a te e grazie del commento 😘