Articolo aggiornato nel maggio 2020, due anni dopo averlo scritto. Oggi mi appare lucidamente come quel che è: un simpatico esempio di cervello in stress post-traumatico. E no, non sono ancora guarita.
Da piccola, quando ancora non credevo alla morte, sottostavo già a un certo influsso. Ero già attratta dal declino e dalla manomissione, senza saperlo.

Provavo una segreta soddisfazione quando, durante una corsa spensierata, cadendo mi sbucciavo le ginocchia. Mi rialzavo esultando tra me e me, pregustando il rito della medicazione: avevo diritto al Mercurocromo, e alla sua grossa macchia disinfettante rosso vivo da portarmi in giro con orgoglio sulla pelle, sfoggiandola come un accessorio stiloso o un tatuaggio temporaneo, o la benda nera di un pirata giocattolo. Come se quel marchio in evidenza mi rendesse automaticamente più coraggiosa. Mi serviva da amplificatore del brio e dell’energia vitale. Ma il bello doveva ancora arrivare.
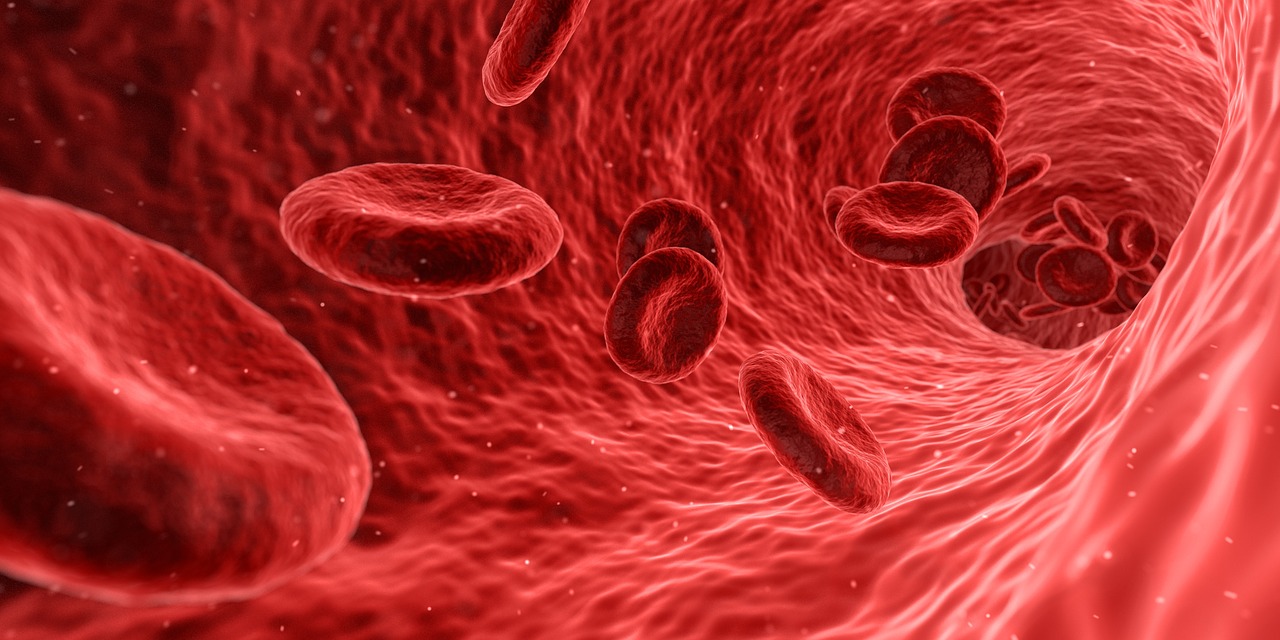
Dopo un po’, sulla ferita si formava la crosta, che potevo grattare via per poi vederla riformarsi, testarda, e diventava una lotta: avrei grattato di più io o si sarebbe riformata di più lei, fino a sparire senza lasciare traccia? Alla fine vinceva lei, e insieme a lei la sanità, ma le davo un gran filo da torcere. Per vedere fin dove potevo insistere. Anche allora le cose le facevo bene, e quindi grattavo con precisione e puntualità, osservando come un entomologo con la sua lente, col paziente e dedito amore dell’attesa. Forse, anche perché un po’ avevo già intuito che sabotare per mettere alla prova il limite delle situazioni era una pratica creativa e appagante. Un impenetrabile spazio di libertà, che poteva restare privato.

Ecco, a volte per la mia ferita di adulta sogno un bel trattamento di Mercurocromo, dal colore denso e illuminante di un evidenziatore. Un pigmento speciale in cui tuffarmi impregnando tutto il mio corpo; visibile a migliaia di chilometri di distanza e anche attraverso i pixel. Un pigmento allertante che illustri le cose al posto mio, che mi risparmi tante parole comunque non spese, ma che forse dovrebbero essere dette, di nuovo, e che invece se ne stanno lì, sospese, ignorando se un giorno verranno fatte uscire oppure no. Sogno una nuotata in apnea in un silos di liquido fluorescente, che sia più efficace e funzionale della mia inclinazione a sviscerare, a rivangare, a sezionare al microscopio tra me e me, per poi non dire; che piuttosto mi renda radioattiva fuori, ma che sappia disinfettarmi dentro, sollevarmi. Sarebbe più semplice, e spiegherebbe per me perché certe volte non mi va di uscire, di andare, di fare.
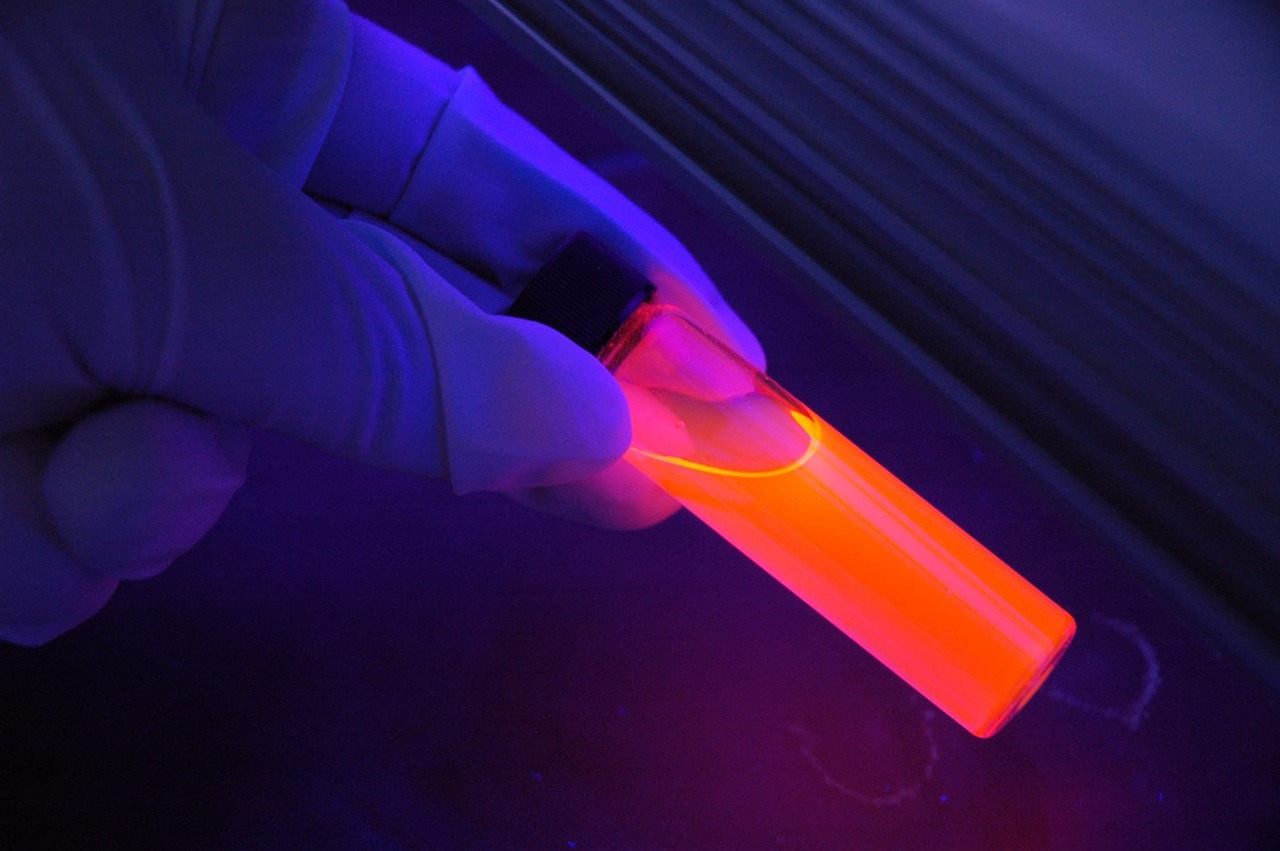
Perché la mia ferita è differente: c’è, ma non si vede. Anche lei ce la mette tutta per rimarginarsi, è tenace e precisa, fa un sacco di progressi e si riempie di nuova vita e qualche volta anche di un arcobaleno o due, però poi arrivo io, la disturbatrice di me stessa, e ricomincio a grattare. Gratto e gratto perché a volte c’è bisogno di vederlo, quel rosso che sta sotto, occorre dare corpo a quella possenza e farla sgorgare, perché non si sfugge a quell’irrefrenabile impulso umano a essere d’impiccio, a mandare in vacca. Serve far uscire un po’ di sangue dalla retina, qualche goccia ancora, anche quando tutti intorno a te si sono stufati di sentire la storiella ormai innocua a furia di essere pronunciata e tu a loro non vuoi dirla più, e poi sembra che tu stia così bene, guarda quante cose fai. È un sangue che vedo solo io, quel rosso su cui ancora, rimemorando, cammino per mettermi in salvo. Il rosso di persone amate da qualcuno rimasto a casa ad aspettarle, il rosso che dovrebbe restarsene dentro a scorrere tranquillo e che invece io ho visto spandersi, pigmentato di morte, solo perché passavo di lì, in quegli istanti che ci hanno derubati tutti. Rosso su cui ho camminato e che per un miracolo non è stato il mio, calpestato da qualcun altro. Rosso fluo, alterato, ingiusto e innaturale, marmoreo e definitivo. E allora lo spremo da me stessa. Perché a volte devo tornare lì. Fa parte del processo. Mi immobilizzo. E non voglio. Non voglio niente. Aspetto.
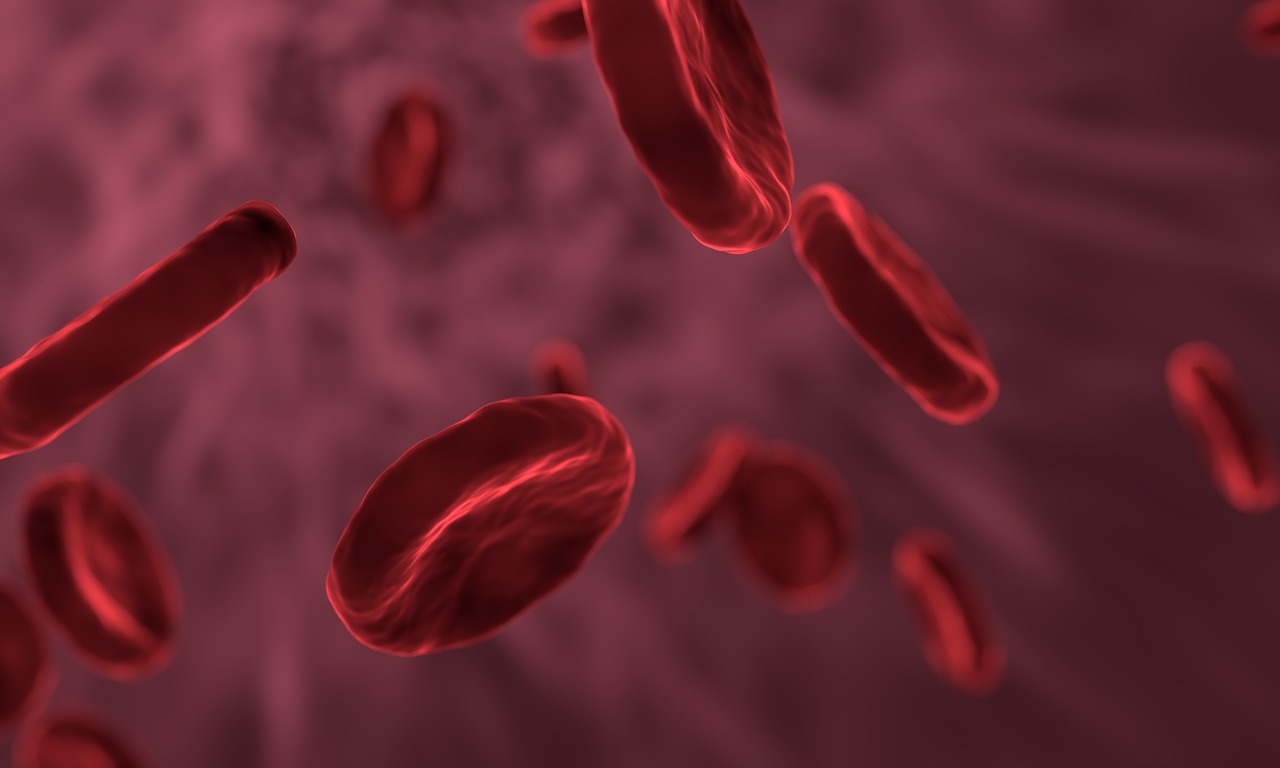
La vita va avanti e si vedono posti e si fanno cose e si ama e si sogna e si stringe amicizia, ma la verità è che esistono cesure dopo le quali non si può più vivere nello stesso modo. A volte mi chiedo tout court se si possa vivere. Intorno a me la gente si riproduce. Si riproduce e si moltiplica. E io, a tratti, rimango fluorescente, anche se non si vede.

Poi passa, in un guizzo rosso intenso. Come il rossetto che ho messo oggi. Aspetto.
Vincerà la sanità? Quando?

(Foto: Pixabay)
